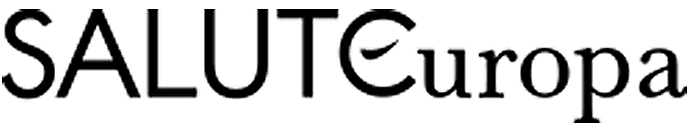Risponde di omicidio colposo lo psichiatra che, avendo in cura una paziente affetta da psicosi maniaco-depressiva ed omettendo di sorvegliarla adeguatamente, non ne impedisce il suicidio.
Il caso
Il caso riguarda una donna che, ricoverata in una clinica specialistica a causa di un disturbo bipolare in fase depressiva, caratterizzato da spinte suicide, si allontanava dalla stanza in cui era ricoverata, raggiungeva un’impalcatura allestita all’esterno della struttura ospedaliera e si lasciava cadere nel vuoto, uccidendosi.
A seguito di questo tragico evento, la Corte d’appello di Catania confermava la decisione con la quale il Tribunale di Catania, riconosciuto il reato di omicidio colposo in violazione della disciplina sull’esercizio della professione medica, aveva condannato il medico psichiatra in servizio presso il reparto di neuropsichiatria della casa di cura.
All’imputato era stata contestata una condotta colposa consistita nell’omessa adozione, in violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, delle adeguate misure di protezione idonee a impedire che la paziente si desse la morte.
Contro la sentenza d’appello il medico proponeva ricorso per cassazione, a seguito del quale la Suprema Corte (sezione quarta penale) ha emesso la sentenza 1° agosto 2016, n. 33609.
Il ricorso per Cassazione
La Cassazione ha ripercorso l’iter logico seguito dalla Corte d’Appello nel pronunciare sentenza di condanna nei confronti del medico, vagliandone la correttezza.
Riguardo all’elemento soggettivo del reato, nel caso specifico consistito in un comportamento colposo dell’imputato, la Corte d’Appello aveva evidenziato come la vittima soffrisse da lungo tempo di una grave forma di depressione, circostanza attestata dalla diagnosi di ingresso nella casa di cura: dalla cartella clinica, infatti, era emersa in maniera evidente una depressione del tono dell’umore, ansia, insonnia e, soprattutto, un’ideazione negativa a sfondo suicidario. La patologia psichiatrica della vittima era stata quindi inquadrata nelle forme di un “disturbo bipolare II” o psicosi maniaco-depressiva, che si caratterizza per l’alto rischio di suicidio, valutabile come trenta volte superiore rispetto quello della popolazione generale. Fra l’altro, in precedenza la donna aveva già posto in essere ben due tentativi di suicidio.
Accertata tale patologia sulla vittima, la Corte d’Appello aveva ritenuto dimostrato il carattere di soggetto ad alto rischio della paziente, per la quale, secondo le linee-guida più riconosciute nel settore specifico psichiatrico, sarebbe stato assolutamente necessario procedere, oltre a tutti gli interventi di tipo farmacologico, a una stretta sorveglianza, intesa come assistenza della paziente ventiquattr’ore su ventiquattro. Purtroppo però tale misura non fu in nessun caso e in nessun momento adottata nei confronti della paziente, che risultò pienamente libera di muoversi per tutto l’edificio senza alcuna sorveglianza.
Sul punto la Cassazione, nella pronuncia in commento, ha ricordato il costante orientamento giurisprudenziale in base al quale il medico psichiatra deve ritenersi titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, con la conseguenza che lo stesso, quando sussista il concreto rischio di condotte autolesive, anche suicidiarie, è tenuto ad apprestare specifiche cautele (Sez. 4, Sentenza n. 48292 del 27/11/2008).
Il giudizio della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto, dunque, condivisibile il giudizio della Corte d’Appello circa la grave negligenza riconosciuta in capo all’imputato; infatti, le condizioni della paziente, i suoi precedenti tentativi di suicidio, nonché la diagnosi formulata in fase di accettazione, avrebbero dovuto rendere largamente prevedibile il rischio di un rinnovato tentativo di suicidio della donna, che viceversa l’imputato ebbe a trascurare e, dunque, a gestire con manifesta superficialità e negligenza.
La Cassazione ha ritenuto, dunque, che con motivazione immune da vizi d’indole logica o giuridica, la Corte d’Appello aveva tratto la conclusione che, laddove l’imputato avesse assicurato una stretta e continua sorveglianza della paziente, l’evento lesivo oggetto di giudizio non si sarebbe verificato.
Conseguentemente, a parere della Cassazione il medico era stato correttamente ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo e per tale ragione condannato dalla Corte d’Appello.
Inoltre la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 3 della cosiddetta “legge Balduzzi” (legge 8 novembre 2012 n. 189), il quale stabilisce che “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve“. Infatti, nel caso di specie proprio la mancata osservanza delle regole tecniche, trasfuse nelle linee-guida da osservare, ha determinato il tragico evento. Nell’occasione, appunto, le buone pratiche scientifiche avrebbero imposto la predisposizione di una stretta e continua sorveglianza della donna ventiquattr’ore su ventiquattro, cosa che venne dall’imputato totalmente omessa.
Diego Colangelo
Ultimi post di Diego Colangelo (vedi tutti)
- La riforma della responsabilità medica: le principali novità - Aprile 5, 2017
- Eutanasia: la situazione normativa in Italia - Febbraio 27, 2017
- Cartella clinica incompleta: in caso di evento dannoso scatta la prova presuntiva a sfavore del medico - Novembre 18, 2016