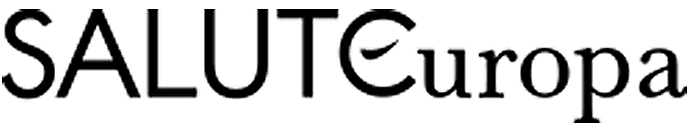“Il futuro è già qua, è solo che non è distribuito equamente” William F. Gibson
Nella maggioranza dei villaggi del mondo, una domanda che può scatenare gli incubi peggiori è se la pecora malata morirà lasciando i bambini senza latte. Pare invece che a bordo delle piscine della Silicon Valley tenga banco un’altra domanda: ma gli androidi sognano pecore elettriche?
Entrambi i dilemmi tendono a ripresentarsi periodicamente: sotto il solleone africano, ogni volta che un’epizoozia falcidia gli sparuti capi di bestiame; sotto quello californiano, quando si rispolvera Do Androids Dream of Electric Sheep?, il romanzo cult di Philip K. Dick. È già successo nel 1982 con il film Blade Runner e nel 2017 con il suo seguito Blade Runner 2049; sta accadendo di nuovo quest’anno, in cui ricorre il cinquantenario del romanzo.
La diversità dei problemi che attanagliano gli uomini è davvero imbarazzante, se proprio non vogliamo dire disgustosa: il divario tra chi non ha di che vivere e chi si svaga nelle multisale climatizzate è tale, come si diceva un tempo, da gridare vendetta al cospetto di Dio. Questa è la prima considerazione da tenere presente se vogliamo guardare, dal balcone dorato del Primo Mondo, al futuro dell’informatica e della robotica; è una sorta di schiaffo zen, capace di richiamarci alla realtà al momento opportuno, in modo da mantenere il giusto senso delle proporzioni.
D’altro canto, gli sviluppi della vita e dell’intelligenza artificiali non vanno sottovalutati, sia perché prima o poi si estenderanno all’intera umanità, sia perché sollevano già oggi profonde questioni esistenziali. Apparentemente, la domanda centrale è se le macchine possano un giorno diventare persone; e poiché si tratta di androidi, ci si chiede se possano tramutarsi in persone umane. Possiamo ricamarci su precisando che ci riferiamo solo alle macchine che processano informazioni, oppure che l’eventualità di raggiungere l’autocoscienza riguarda più che altro la rete informatica, o ancora che bisogna distinguere tra l’automazione di un sillogismo e quella dell’empatia; ma in fondo ciò che molti vorrebbero sapere è se Roy Batty, il deuteragonista di Blade Runner, è un replicante o un uomo.
Molti, ma non tutti. Io, per esempio, prima di chiedermi se ciò che mi sta di fronte sia un androide o un membro della specie Homo sapiens, da buon biologo vorrei saperne un po’ di più sulla sua anatomia (ce l’ha la colecisti?), fisiologia (va al bagno?), sviluppo (ha per caso avuto le mestruazioni?) e sulle sue eventuali patologie (come va con le bronchitelle invernali?); ovviamente, dovrei anche documentarmi sul suo statuto tassonomico (in un eventuale incrocio con un membro di Homo sapiens produrrebbe prole fertile?) e sui suoi rapporti filogenetici (discende da Australopithecus?). Insomma, parlando da uomo, vorrei sapere se è carne della mia carne e osso delle mie ossa.
Il tono un pò scanzonato di questi rilievi non serve a smontare il romanzo di Dick o il final cut di Blade Runner – che nel loro genere sono due gran pezzi di bravura – ma a suggerire che essi mettono in scena non tanto un futuro oggettivo quanto le paure odierne. Come i millenarismi apocalittici non parlano di comete pestilenziali e profezie Maya ma dei timori della loro epoca, così ogni distopia inscena i nostri fantasmi, il luctus et angor del presente. Procediamo allora con calma ad esaminare alcune di queste ansie e angosce.
Il primo timore è quello dell’inganno. Funziona più o meno così: tu conosci una persona, parli con lei del più e del meno, magari ti piace pure, e poi un bel giorno scopri con orrore che sotto la sua pelle si nasconde un groviglio di fili metallici e circuiti elettronici. Non dev’essere piacevole vivere in un mondo dove «chi» passeggia per strada potrebbe essere tanto una persona quanto un cyborg: in una Metropolis dove le macchine hanno fattezze androidi o ginoidi – insomma umanoidi, troppo umanoidi – il timore dell’inganno sarebbe costantemente dietro l’angolo. D’altro canto, può anche darsi che questo sospetto scatenerebbe una class action contro la ditta che non ha etichettato opportunamente i suoi prodotti, e contro la sua pubblicità ingannevole. In altre parole, l’inganno del finto umano può dar fastidio, ma non è diverso da qualsiasi altro inganno perpetrato da persone (vere) ai danni di altre persone (vere).
Una seconda paura è che le macchine prendano il sopravvento sull’umanità, riducendola in schiavitù o eliminandola. Nonostante varie predizioni in proposito, una simile singolarità tecnologica sembra largamente di là da venire; tuttavia si possono individuare alcune forme più concrete in cui potrebbe materializzarsi. La prima è che le smart factory eliminino sempre più posti di lavoro; si paventano perciò catene di montaggio robotizzate, controllate da pochi tecnici iperspecializzati, dove sistemi ciberfisici che non dormono e non scioperano sfornerebbero automobili senza sosta, garantendo profitti stratosferici alla proprietà; e tuttavia, se torme di operai venissero garbatamente licenziate non si capisce a chi si potrebbero vendere le automobili prodotte. Un altro timore è che non tanto le macchine, quanto l’élite che le possiede e controlla possa formare una società a parte, condannando il resto dell’umanità a sopravvivere in un apartheid subumano e disumano; ma questa condizione, lungi dall’essere una prospettiva futura, per molti versi è sempre stata la realtà per i cafoni e gli anawim di tutto il mondo. Un’ultima possibilità è che il sopravvento delle macchine si realizzi in un modo diverso ma non meno inquietante, cioè nella forma di un’umanità sibarita e accidiosa, ridotta a farsi imboccare da sofisticati robot; ma si può sperare che vi saranno sempre donne e uomini capaci di impegnarsi costruttivamente, mentre si deve purtroppo accettare che anche le tendenze malvagie saranno sempre pronte all’azione.
Per scoprire il terzo timore occorre scavare fino al nucleo stesso dell’essere uomini: un androide indistinguibile da una persona, cioè, induce a sospettare che in fondo la persona sia indistinguibile dall’androide. È la paura di scoprirsi improvvisamente macchina, di accorgersi in un istante di folgorazione che non si è umani; può presentarsi come timor panico di dissolversi nell’indifferenza universale, o al contrario come l’inconfessata pulsione freudiana a regredire nell’inerzia dell’inorganico. Ora, il problema preliminare – che ho sinora sottaciuto – è che quando si parla di macchine non si sa bene a cosa ci si riferisce: stiamo parlando delle fontane artificiali che René Descartes presentava come referenti tecnologici del suo dualismo antropologico, o dell’automa cibernetico di William R. Ashby, ridotto a una funzione matematica ricorsiva? Le cose si complicano ulteriormente se cerchiamo di definire l’uomo: si tratta dello zoon logon echon di Aristotele o dell’homme machine del materialista La Mettrie, dell’homo corpore erecto nudo del naturalista Linneo o dell’indefinibilità giunta a sé stessa del teologo Karl Rahner? Finché non saremo in grado di diradare questa selva di significati possiamo prendere tali paure per quel che sono, e cioè fantasmi privi di sostanza; nel frattempo ci si può comunque ricordare che chi scopre con orrore di non essere uomo è, precisamente e anticipatamente, un uomo: anche se l’uomo fosse una macchina, la più fragile di tutte le macchine, sarebbe però una macchina pensante.
C’è un ultimo passo da compiere. Da un certo punto di vista, tutti questi timori ruotano intorno ad una questione radicale: qual è il senso della vita umana? Se la macchina minaccia la nostra esistenza, se i padroni delle macchine umanoidi smaniano dalla voglia di sfruttare uomini ridotti a macchine, se la nostra stessa identità personale è messa in dubbio da replicanti sempre più simili a noi, ebbene: che senso ha tutto ciò? In un futuro più o meno lontano non finiremo per scoprire di aver perso del tutto e per sempre il senso del nostro stare al mondo?
Già in passato molti pensatori hanno proclamato l’assurdità dell’esistenza umana e dell’autocoscienza; forse il loro fronte si sta oggi persino allargando, se pensiamo a quei neuroscienziati che insinuano dubbi sull’io personale e sul libero arbitrio. Ora, immaginiamo per un attimo che si dimostri che non c’è alcun senso dietro alle nostre vicende; supponiamo che si scopra che l’amore è solo un insensato balletto di particelle elementari, perfettamente replicabile in un androide. Cosa ne sarebbe allora delle infinite vite umane che hanno brillato per un istante nel buio di un universo senza senso, per poi spegnersi per sempre? Soprattutto, cosa ne sarebbe delle immani sofferenze che hanno segnato la stragrande maggioranza di quelle esistenze? Se il replicante rivela che non c’è alcun senso al di là di flussi elettronici e reti neurali, l’esistenza umana non si ridurrebbe ad una macroscopica impostura, alla più grande fregatura dell’universo? Vivere e soprattutto soffrire, o addirittura illudersi di farlo, a che pro? Meglio sarebbe non essere mai nati, direbbe il poeta.
Ma se c’è una speranza che dia senso alla vita del povero cristo che teme per la sua pecora, se l’ecce homo resta la pietra di paragone su cui saggiare ogni elucubrazione futurologica e la pietra d’inciampo di ogni volontà tirannica e faustiana, allora i nostri sogni possono e devono essere più grandi di quelli degli androidi. We have a dream, certo, ma non sogniamo pecore elettriche. Noi sogniamo e lavoriamo per un futuro che sostenga, custodisca e celebri il corpo elettrico dell’uomo, autocosciente e personale, libero e vivo. Non solo cantiamo con Walt Whitman the body electric, ma sappiamo anche perché: perché caro cardo salutis, il corpo è il cardine di una vita umana piena e gioiosa.
Pietro Ramellini
Ultimi post di Pietro Ramellini (vedi tutti)
- We have a dream, ovvero: quale futuro sognare e perché - Ottobre 12, 2018
- Uomo e Intelligenza Artificiale: un piccolo manuale di sopravvivenza - Giugno 25, 2018
- Armi antiche contro guerre nuove - Marzo 29, 2018